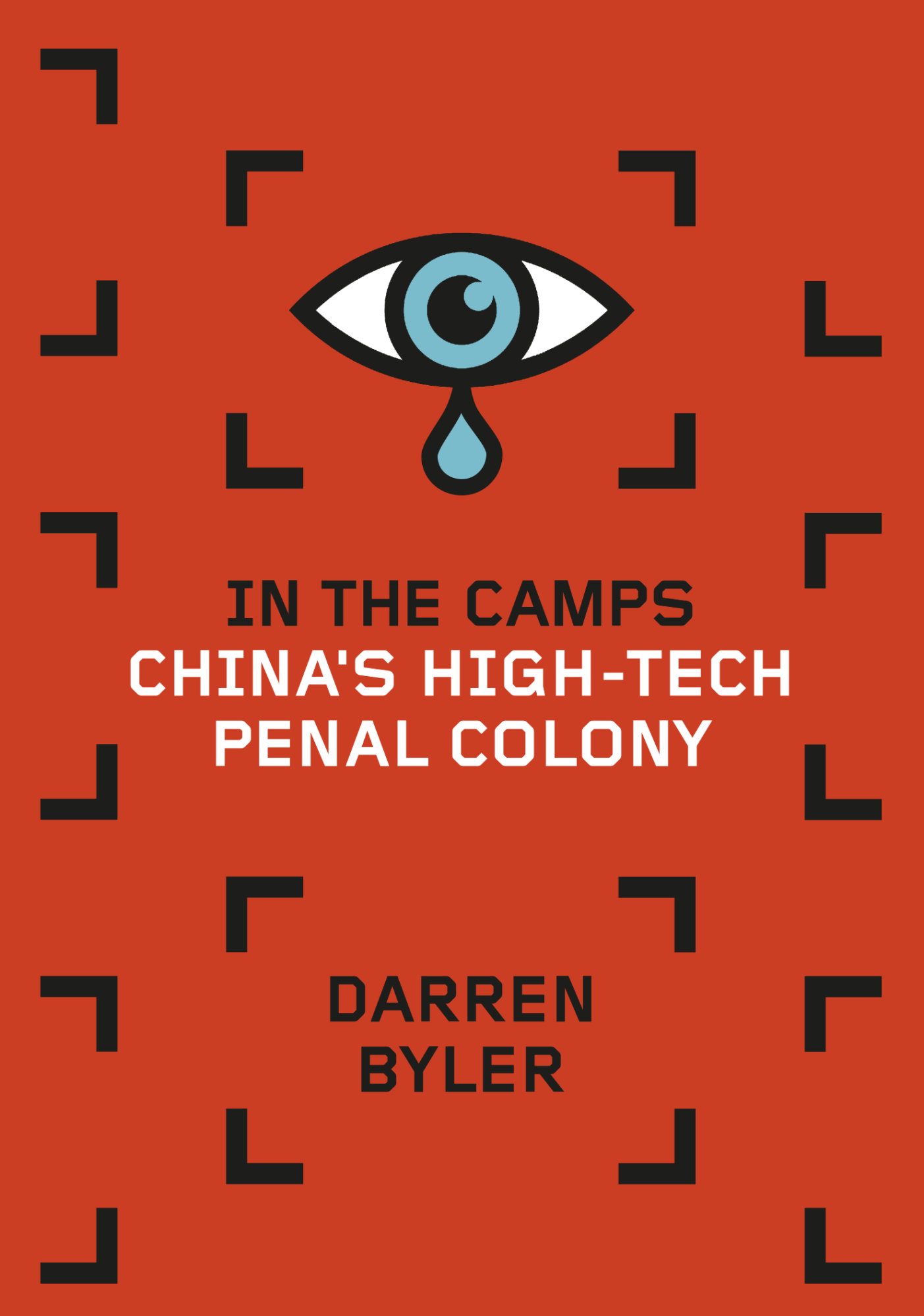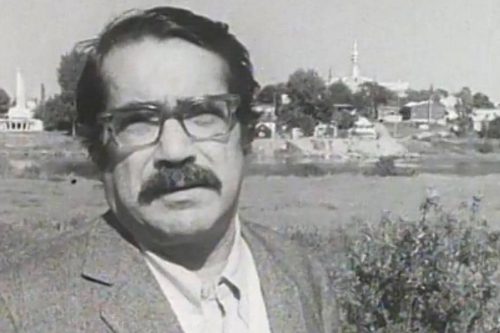La storia di Vera
Una studentessa dell’Università di Washington, originaria dello Xinjiang, invischiata nelle maglie della sorveglianza cinese
| di Darren Byler |
In un giorno imprecisato dell’estate del 2019, nella città cinese di Kuitun, un ausiliare di polizia dà un colpetto sulla spalla a una giovane studentessa dell’Università di Washington che si fa largo fra la folla del mercato. La ragazza, Vera Zhou, non si accorge subito di lui, perché cammina fra la gente ascoltando musica con le cuffie. Quando si volta e vede l’uniforme nera, impallidisce. Parlando in cinese, la lingua madre di Vera, il poliziotto la invita a seguirlo nella vicina stazione della polizia di quartiere, una delle oltre settemila stazioni di sorveglianza presenti nella regione.
All’interno del grigio edificio squadrato, Vera scopre su un monitor il proprio volto, incorniciato da un quadrato giallo. Su altri schermi, i volti delle altre persone che affollano il mercato sono racchiusi in quadrati verdi. Un riquadro nero accanto al fotogramma ad alta definizione del suo viso mostra i suoi dati personali. Dicono che è una hui, appartiene a un gruppo di cinesi musulmani forte di circa un milione dei quindici milioni di musulmani che abitano la Cina nordoccidentale. L’allarme è scattato perché Vera si è avventurata fuori dalla griglia di controllo del quartiere in cui è confinata. In quanto ex detenuta in un campo di rieducazione, non le è permesso spostarsi in altre zone della città senza il consenso esplicito dell’unità di controllo del suo quartiere e dell’Ufficio di pubblica sicurezza. Il quadrato giallo che incornicia il suo viso sullo schermo indica che il sistema di recinti digitali che monitora i musulmani della regione ancora una volta l’ha considerata una “precriminale”. Vera mi ha raccontato che in quel momento si è sentita quasi soffocare.
Kuitun è una cittadina di circa 285.000 abitanti situata nella prefettura di Tacheng, una parte della regione dello Xinjiang che confina con il Kazakistan. Vera era intrappolata lì dal 2017, quando, a metà del primo anno del corso di geografia all’Università di Washington (dove io insegnavo), aveva improvvisamente deciso di tornare a casa per vedere il suo ragazzo. Una sera, all’uscita da un cinema di Urumqi, il capoluogo regionale, il ragazzo aveva ricevuto una chiamata: lo invitavano a recarsi in una stazione di polizia locale. Lì gli agenti gli dissero di dover interrogare Vera per via di alcune attività online sospette. Aveva usato una VPN – una virtual private network – per accedere a “siti web illegali”, come il suo account Gmail dell’università. Questo, come le avrebbero spiegato in seguito, era considerato un “indizio di estremismo religioso”.
Vera non aveva capito subito la situazione. Sulle prime gli agenti erano stati piuttosto vaghi riguardo a ciò che sarebbe successo, forse perché volevano evitare che il suo ragazzo, che non era musulmano e apparteneva all’etnia maggioritaria han, facesse una scenata. Le avevano solo detto di aspettare lì, all’interno della stazione.
Quando chiese loro se fosse in arresto si rifiutarono di rispondere.
“Si sieda e basta,” le dissero. A quel punto, piuttosto spaventata, chiamò il padre che era a casa, nella loro città, e gli raccontò l’accaduto. Infine una camionetta della polizia si fermò davanti alla stazione. Gli agenti la fecero salire nel retro e, quando il suo ragazzo si fu allontanato, la ammanettarono con le mani dietro la schiena e la spinsero bruscamente sul sedile.
Precriminali
Vera Zhou pensava che la guerra al terrorismo non potesse avere nulla a che fare con lei. Si considerava una ragazza alla moda, non religiosa, con una predilezione per gli orecchini vistosi e gli abiti neri. Aveva frequentato le scuole superiori vicino a Portland, in Oregon, e stava studiando in una delle più quotate università americane per diventare urbanista. Aveva in progetto di ricongiungersi con il suo ragazzo dopo la laurea e di fare carriera in Cina, dove riteneva che l’economia fosse in espansione. Non sapeva nulla della nuova legge per la sicurezza di Internet entrata in vigore nella sua città natale e in tutto lo Xinjiang all’inizio del 2017 e non sapeva che i precriminali – così li definivano le autorità statali – venivano identificati in quel modo prima di essere incarcerati. Non sapeva che il nuovo segretario regionale del partito aveva ordinato di “fermare tutte le persone sospette” nel contesto della “guerra popolare al terrorismo”.
In quel momento, seduta nel retro della camionetta e in preda alla paura, sentì che stava perdendo il controllo. Gridò, con il viso rigato di lacrime: “Perché mi fate questo? Il nostro paese non protegge gli innocenti?” Le sembrava uno scherzo crudele, come se le avessero assegnato una parte in un film dell’orrore, e pensava che, se avesse dato le risposte giuste, i poliziotti si sarebbero resi conto di aver commesso un errore.
Vera fu reclusa per qualche mese, assieme ad altre undici donne musulmane di etnia minoritaria, in una cella al secondo piano di un’ex stazione di polizia nei sobborghi di Kuitun. Come lei, altre sue compagne di cella erano accusate di “precrimini” informatici. Una donna di etnia kazaka aveva installato WhatsApp sul telefono per restare in contatto con i suoi soci in Kazakistan. Una donna uigura che vendeva smartphone in un bazar aveva permesso a molti clienti di registrare le proprie schede SIM usando la sua carta di identità.
Ad aprile del 2018, senza preavviso, Vera e diverse altre detenute furono rilasciate, a condizione che si recassero regolarmente presso l’ufficio per la stabilità sociale della loro zona e non si allontanassero dal quartiere di residenza.
Ogni lunedì, il funzionario di sorveglianza di Vera la obbligava a partecipare alla cerimonia di alzabandiera del quartiere, cantare ad alta voce l’inno nazionale e proclamare la sua lealtà al governo cinese. A quel punto, dopo che numerosi racconti di detenzioni per crimini informatici si erano diffusi in città, tutti sapevano che i sistemi per la sorveglianza automatica di internet installati di recente erano in grado di individuare comportamenti sospetti. Come tutti gli altri, Vera cambiò il suo modo di stare in rete. Ogni volta che il funzionario per il controllo della stabilità sociale a cui era affidata pubblicava qualcosa sui social, era sempre la prima a mettere un like e a condividere il contenuto nel suo account. Come tutti i suoi conoscenti, anche lei iniziò a “diffondere energia positiva” promuovendo attivamente l’ideologia di stato.
Una volta tornata nel suo quartiere, si rese conto di essere cambiata. Pensava spesso alle centinaia di detenuti che aveva visto nel campo. Temeva che molti di loro non ne sarebbero mai usciti, perché non parlavano cinese ed erano sempre stati musulmani praticanti. Disse che il tempo trascorso nel campo le aveva fatto mettere in dubbio la sua sanità mentale. “Mi capitava di pensare: ‘forse non amo abbastanza il mio paese,’” mi ha confessato. “Forse penso solo a me stessa.”
Ma Vera sapeva anche che quello che le era successo non era colpa sua. Era il risultato di un’islamofobia istituzionalizzata e diretta contro di lei. E sapeva con assoluta certezza che ciò che veniva imposto agli uiguri e ai kazaki per via della loro differenza etnico-razziale, linguistica e religiosa era di una crudeltà smisurata.
“Iniziai a starmene sempre più spesso chiusa in casa”
Come tutti i detenuti, prima di essere portata nei campi Vera era stata sottoposta a una rigorosa raccolta di dati biometrici, parte del processo di screening della popolazione noto come “esami fisici per tutti”. La polizia le aveva scansionato il volto e le iridi, registrato l’impronta vocale e raccolto un campione di sangue, le impronte digitali e il DNA, aggiungendo questi dati estremamente precisi a un immenso database usato per mappare il comportamento della popolazione della sua regione. Le avevano anche sequestrato il telefono, per cercare al suo interno e negli account social qualsiasi traccia di immagini islamiche, collegamenti con stranieri e altri segni di “estremismo”. Quando infine glielo restituirono, non conteneva più applicazioni prodotte negli Stati Uniti, come ad esempio Instagram.
Dopo qualche settimana aveva iniziato a escogitare dei modi per evitare le postazioni di sorveglianza collocate ogni poche centinaia di metri. Al di fuori delle zone di maggior passaggio, molte erano dotate di normali telecamere di sorveglianza che non erano in grado di rilevare i volti in tempo reale. Dal momento che assomigliava agli han e parlava il cinese standard, agli addetti alla sicurezza dei checkpoint diceva semplicemente di aver dimenticato a casa la carta d’identità e rilasciava un numero falso. Oppure passava attraverso la “corsia verde” del checkpoint, come facevano gli han, e ignorava la polizia.
Una volta però, mentre andava al cinema con un’amica, si era dimenticata di fingere di essere una han. Al checkpoint del cinema aveva messo la carta d’identità sullo scanner e guardato la telecamera. Subito l’allarme si era messo a suonare e gli ausiliari di polizia del centro commerciale l’avevano tratta in disparte. Mentre l’amica spariva fra la folla, Vera aveva freneticamente cercato di cancellare i suoi account social e di eliminare i contatti di persone che rischiavano di essere arrestate perché la conoscevano. “In quel momento mi resi conto che avere degli amici era davvero pericoloso. Iniziai a starmene sempre più spesso chiusa in casa.”
Infine, come molti ex detenuti, Vera fu costretta a lavorare gratis. Sapendo che aveva frequentato l’università negli Stati Uniti, il comandante di polizia del quartiere chiese al suo funzionario di sorveglianza di assegnarle il ruolo di tutor, perché potesse insegnare l’inglese ai suoi bambini.
“Pensai di chiedergli di pagarmi,” ricorda Vera. “Ma mio padre disse che dovevo farlo gratis. E mi dava del cibo da portargli, per mostrare quanto era desideroso di compiacerlo.”
Il comandante non parlò mai di un compenso.
Nell’ottobre del 2019 il funzionario di sorveglianza di Vera le disse che era molto contento dei suoi progressi e che le avrebbe consentito di riprendere gli studi a Seattle. Le fecero firmare un impegno a non parlare di ciò che aveva vissuto. Il funzionario le disse: “Tuo padre ha un buon lavoro e andrà presto in pensione. Non te ne dimenticare.”
Traduzione di Alessandra Neve
L’autore
 Darren Byler è un etnografo, ricercatore di antropologia alla School for International Studies della Simon Fraser University di Vancouver. I suoi scritti, oltre che da numerose riviste scientifiche, sono pubblicati da «The Guardian», «Foreign Policy», «Noema Magazine», «Prospect Magazine», «Guernica», «ChinaFiles».
Darren Byler è un etnografo, ricercatore di antropologia alla School for International Studies della Simon Fraser University di Vancouver. I suoi scritti, oltre che da numerose riviste scientifiche, sono pubblicati da «The Guardian», «Foreign Policy», «Noema Magazine», «Prospect Magazine», «Guernica», «ChinaFiles».
Dal 2011 al 2018 Byler ha condotto il suo lavoro etnografico nello Xinjiang, entrando in contatto con moltissime persone, intervistandole e raccogliendone le testimonianze per documentare le trasformazioni di quella regione che, nel corso dell’ultimo decennio, hanno subito un’accelerazione dai risvolti inquietanti.
Lo Xinjiang è situato all’estremità occidentale della Cina, confina con i paesi dell’Asia centrale e ospita una popolazione composta per la maggior parte da uiguri, turcofoni e musulmani, e in parte minore da kazaki e chirghisi. La percentuale di cinesi han, una volta in netta minoranza, negli ultimi decenni è aumentata, grazie a un programma di sovvenzioni all’immigrazione volto a sinizzare la popolazione per uniformarla, dal punto di vista culturale e religioso, al resto della Cina.
Una volta concluse le ricerche sul campo, Byler si è dedicato alla stesura dei risultati del suo lavoro e ha pubblicato diversi studi, un libro di taglio accademico, Terror Capitalism: Uyghur Dispossession and Masculinity in a Chinese City, e un’opera dal taglio più narrativo, In the Camps.
Credits
Il brano proposto è un estratto dal libro In the Camps. China’s High-Tech Penal Colony, pubblicato a New York da Columbia Global Reports il 12 ottobre 2021. La versione originale dell’estratto, più estesa di quella qui proposta, è apparsa l’11 ottobre 2021 sulla rivista «MIT Technology Review» con il titolo The covid tech that is intimately tied to China’s surveillance state. La traduzione è stata effettuata e viene qui condivisa con il gentile consenso dell’autore. La foto in alto è presa online.