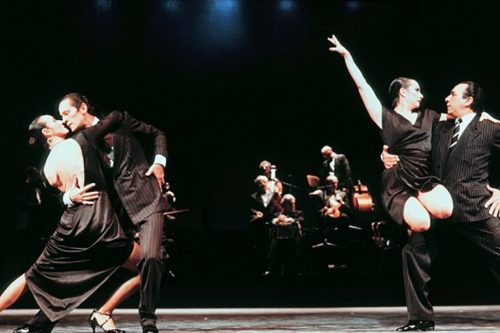Lungo i binari delle ferrovie fantasma
Un estratto da On the Shadow Tracks, il viaggio-inchiesta di Clare Hammond lungo le ferrovie birmane
| di Clare Hammond |
Di ritorno a Yangon dopo una visita a Dawei, il capoluogo della regione del Tanintharyi – una lunga striscia di terra che dal cuore del Myanmar si protende verso sud come la coda di un aquilone –, feci una ricerca su Google con le parole “ferrovia del Tanintharyi”.
Trovai articoli in lingua birmana che parlavano di sospensioni del servizio, lavori programmati sulle linee e progetti per la costruzione di una nuova ferrovia che avrebbe collegato il Tanintharyi alla provincia thailandese di Kanchanaburi. Trovai post di Facebook che riferivano di disastri ferroviari, della consegna di nuove carrozze di fabbricazione cinese e di contratti per il trasporto merci firmati dal ministro delle Ferrovie. Scorrendo i risultati, trovai anche diverse pagine di Wikipedia in birmano, la maggior parte delle quali conteneva informazioni fuorvianti. Per esempio quella su Dawei, il capolinea meridionale, diceva che la città non era raggiunta dalla ferrovia.
La stessa ricerca in inglese mi fece scoprire una pagina di Wikipedia intitolata “Tanintharyi Line”, che conteneva informazioni sullo scartamento dei binari, sull’operatore (Myanma Railways) e sulle date di costruzione della linea (1994-1998). Nessun riferimento alle centinaia di migliaia di persone costrette a lavorare per costruirla o al rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite (ILO), secondo il quale il Myanmar aveva violato la Convenzione sul lavoro forzato «in maniera ampia e sistematica, senza alcun riguardo per […] la dignità umana, la sicurezza e la salute». La pagina non diceva niente nemmeno delle sanzioni imposte alla giunta militare del Myanmar, né forniva altre informazioni che potessero far pensare a qualcosa di diverso da una linea qualunque in una parte poco frequentata del mondo.
Il fatto che ci fossero pochi risultati sul lavoro forzato dimostrava che l’algoritmo di Google non considerava l’informazione rilevante per la ricerca; significava che non c’erano altre persone che cercavano quell’argomento. Da quando si erano svolti i fatti, si era scritto molto poco sul lavoro forzato impiegato nella costruzione della ferrovia. I rapporti delle Nazioni Unite e di altri gruppi, come Amnesty International, che avevo trovato in rete erano stati pubblicati alla fine degli anni Novanta e all’epoca quasi nessuno in Myanmar aveva potuto leggerli; da allora sembrava che non fossero state raccolte altre testimonianze. Tutti gli altri contenuti relativi alla ferrovia del Tanintharyi, senza eccezioni, parlavano di incidenti o del funzionamento della linea (quelli in birmano) oppure di turismo (quelli in inglese) e le successive interazioni degli utenti di Google avevano portato quelle informazioni in cima ai risultati di ricerca. Così la verità sulla violenza perpetrata durante la costruzione della ferrovia era lentamente scivolata nell’oblio.
Ma il problema non era solo che in rete non si trovavano informazioni sulla costruzione della ferrovia. Il fatto è che di ciò che era accaduto nel Tanintharyi non si sapeva quasi niente al di fuori della regione, che anche oggi è isolata dal resto del Myanmar perché lontana dalle città principali e dotata di collegamenti viari di scarsa qualità. La ferrovia, come altre in altre zone del paese, era stata costruita in un periodo in cui la maggior parte della popolazione del Myanmar era isolata, sia dal mondo esterno sia all’interno del paese.
Durante il regime della giunta, il paese aveva reti telefoniche mobili solo nelle città più grandi e il costo delle schede SIM era proibitivo: una scheda poteva costare più di 1500 dollari. I media erano pesantemente censurati, gli spostamenti fisici controllati e la diffusione delle informazioni mediante il passaparola limitata dalle scarse infrastrutture fisiche e dalla paura di punizioni arbitrarie. La stretta dei militari sull’informazione aveva fatto sì che la maggior parte dei loro abusi non fosse mai documentata, men che meno discussa e ricordata collettivamente. Non solo non c’era stato alcun tentativo di fare giustizia, ma gli abusi non erano mai nemmeno affiorati nella coscienza del paese.
Nel 2011, l’impunità era stata il prezzo da pagare per passare a un governo civile parzialmente eletto: i militari avevano inserito nella nuova costituzione del Myanmar la garanzia di non prosecuzione, approvata pochi anni prima da un finto referendum. Aung San Suu Kyi aveva accettato l’accordo e confermato che, durante la transizione, non avrebbe tentato di fare giustizia. Cercare vendetta, così come raccogliere prove e raccontare gli eventi storici, sarebbe equivalso a superare una linea rossa. Da quando è iniziata la transizione politica la libertà di stampa è aumentata ma i giornalisti si sono limitati a occuparsi dell’attualità, non si sono messi a rivangare il passato.
E così, la storia delle centinaia di migliaia di persone costrette a costruire una ferrovia nella regione del Tanintharyi non è mai stata raccontata, se non, forse, nei luoghi in cui è accaduta. Anche lì, però, in genere non se ne parla in pubblico. […] Se si esclude una manciata di testimonianze pubblicate in misconosciuti rapporti delle Nazioni Unite e di altri organismi, rapporti che non hanno mai raggiunto la coscienza nazionale del Myanmar, quelle storie non sono mai state scritte, esistono soltanto nei ricordi dei protagonisti. E quando i ricordi svaniranno sarà quasi come se non fossero mai accadute.
A testimonianza di quanto poco si sa delle ferrovie costruite dai militari del Myanmar, nel 2016, quando ormai vivevo nel paese da due anni, credevo ancora che tutte le sue linee ferroviarie risalissero al periodo coloniale. E dire che vivevo accanto alla stazione centrale di Yangon e spesso, andando e tornando dal lavoro, facevo una deviazione per attraversare la vasta area della stazione, passando accanto ai suoi edifici. Al «Myanmar Times» lavoravo fino a tardi e la sera, per rilassarmi, tornavo a casa passeggiando lungo i binari vuoti, godendomi l’oscurità e il silenzio che regnavano dopo che l’ultimo treno era rientrato in deposito.
Certe sere invece attraversavo il quartiere dei ferrovieri, un complesso di case a un solo piano nel quale vivevano migliaia di lavoratori con le loro famiglie. Le strade strette erano sempre affollate: la gente si ammassava intorno ai televisori per guardare un film coreano o traboccava fuori dalle birrerie; mi piaceva l’atmosfera di comunità che vi si respirava. Durante i fine settimana, ogni volta che potevo, facevo un viaggio in treno: esplorai prima la periferia di Yangon con le linee metropolitane e poi, con i treni notturni, raggiunsi altre città.
Se non fosse stato per il mio lavoro, però, non mi sarei mai resa conto che c’era qualcosa di strano. Da giornalista che si occupava di temi economici, parte del mio lavoro consisteva nello scrivere o editare articoli che parlavano delle infrastrutture del paese, ferrovie comprese. Così, quando nell’estate del 2016 la Asian Development Bank pubblicò un documento programmatico che riguardava la rete ferroviaria del Myanmar, me lo lessi per intero.
Il documento rendeva pubblici per la prima volta molti documenti del ministero delle Ferrovie. Dimostrava che il regime militare aveva speso miliardi di dollari per costruire nuove ferrovie – molte delle quali in seguito abbandonate – in un periodo in cui il paese aveva un disperato bisogno di investimenti in sanità ed educazione. Erano informazioni già abbastanza interessanti per un articolo, ma ciò che conquistò davvero la mia attenzione fu una mappa della rete ferroviaria che metteva in evidenza la dimensione del problema. Il paese era coperto di ferrovie, dalla penisola meridionale del Tanintharyi fino alle montagne contese dello stato settentrionale del Kachin, dalle coste occidentali del Rakhine fino alle irrequiete cittadine del nordest, al confine con la Cina, controllate dalle milizie.
Il rapporto divideva le linee in quattro categorie. Quelle preesistenti, in gran parte costruite dal governo coloniale britannico, costituivano l’ossatura della rete e apparivano anche su altre mappe che mi era capitato di vedere. Della maggior parte delle linee che ricadevano sotto le altre tre categorie – linee inaugurate di recente, linee in costruzione e linee in progettazione – non avevo mai sentito parlare. Molte nuove linee funzionavano solo in parte e su quelle completate non era chiaro se i treni circolassero o avessero mai circolato.
Poco tempo dopo telefonai a uno dei miei contatti birmani, un esperto di ferrovie. «Sì», mi disse, quando accennai alle nuove linee. «Ci sono linee che portano dappertutto».
Gli chiesi se pensava che fosse possibile percorrerle. Disse che non ne era sicuro ma che non gli sembrava una buona idea. «I servizi sono pessimi», mi avvertì. «I treni sono lenti, le tratte piene di scossoni e si corre il rischio di ritrovarsi da soli in una stazione sperduta alle tre del mattino».
Mi disse anche che pochi addetti parlavano inglese. «Molti di loro sono ex militari. Le Myanma Railways sono la casa di riposo dei veterani».
Gli chiesi se sapesse qualcos’altro riguardo alle nuove ferrovie. «Hanno iniziato a costruirle nel 1990», rispose. «È stato terribile. Lavoro volontario. Binari fatti male».
«Lavoro volontario?» gli feci eco io.
«Meglio non indagare troppo, è sempre la stessa storia», rispose. «Una volta in Cina ho visto dei tizi che si sfiancavano per costruire una strada e ho pensato: qualcosa non torna, portano delle divise a righe».
Verso la fine della chiamata gli chiesi di consigliarmi una storia delle ferrovie del Myanmar, mi aspettavo che mi indicasse almeno uno o due titoli.
«Sono molti anni che cerco ma non ne ho ancora trovata nessuna», rispose. «Ci sono vari testi, c’è persino un manuale che contiene date e dettagli delle locomotive, ma temo che la storia dello sviluppo delle ferrovie la dovrai ricostruire da sola».
Per ore, dopo aver parlato con lui, cercai su Google informazioni sul “lavoro volontario”. Trovai e lessi il rapporto pubblicato dalla Commissione d’inchiesta dell’ILO alla fine degli anni Novanta. Fu una lettura avvincente e inquietante: pagine su pagine di testimonianze di estorsioni, violenze fisiche, stupri e assassini che avevano accompagnato la costruzione di grandi infrastrutture in tutto il paese, c’erano anche testimonianze di rifugiati che parlavano degli abusi commessi durante la costruzione delle ferrovie.
La violenza che riempiva quelle pagine contrastava con l’ottimismo che regnava in quel periodo a Yangon. Leggendo interviste che raccontavano nei dettagli gli orrori della vita sotto il regime, iniziai a capire quello che tutti coloro che avevano vissuto nel Myanmar della giunta sapevano già. I militari erano brutali, inflessibili e immensamente potenti. I generali avevano un po’ allentato la presa ma in fin dei conti mantenevano ancora il controllo. Disponevano di un quarto dei seggi in parlamento, un numero sufficiente a garantire il potere di veto sugli emendamenti alla costituzione che loro stessi avevano scritto, e controllavano i ministeri della Difesa, degli Affari di frontiera e degli Interni. La maggior parte dei funzionari, anche nei ministeri presieduti dai civili, era stata nominata dalla giunta e molti erano ex soldati. Non c’era altra scelta che adeguarsi alle condizioni imposte dai militari, investire nel progresso che sembrava avanzare e sperare che il peggio delle atrocità fosse finito.
Dopo aver letto il rapporto della Commissione d’inchiesta dell’ILO, andai a trovare la rappresentante dell’organizzazione a Yangon e mi feci descrivere il sistema dei lavori forzati. Mi spiegò che la pratica era del tutto conforme alle leggi dell’epoca coloniale britannica, ancora vigenti in Myanmar. Il Towns Act del 1907 e il Village Act del 1908 prevedevano l’esazione di lavoro e servizi forzati e stabilivano che i capi villaggio dovessero aiutare i funzionari del governo nei loro doveri pubblici; chiunque rifiutava senza una “motivazione plausibile” poteva essere multato o incarcerato. Nel 1931, quando il Regno Unito aveva ratificato la Convenzione che proibiva il lavoro forzato, non aveva esteso la ratifica alla British India, di cui all’epoca faceva parte anche la Birmania. Poco dopo aver ottenuto l’indipendenza, anche il Myanmar aveva ratificato la convenzione ma, nonostante le ripetute richieste dell’ILO, non aveva mai aggiornato le leggi dell’epoca coloniale.
La rappresentante dell’ILO mi presentò una delle sue colleghe birmane: il padre di R. aveva lavorato alla costruzione della ferrovia del Tanintharyi. Lei, una donna schiva, sedeva con le mani in grembo e raccontava del convoglio di mezzi militari che era entrato nel suo villaggio quando aveva sei anni. I soldati avevano razziato case e cortili e fermato gli uomini, suo padre compreso. Poi li avevano portati in un accampamento e li avevano costretti ad aprire un varco nella giungla per permettere il passaggio della ferrovia. Tre mesi dopo, sopravvissuto alla malaria, il padre era riuscito a scappare dall’accampamento e, attraverso le montagne, era fuggito in Thailandia con tutta la famiglia.
«Il lavoro forzato era molto diffuso in Myanmar», disse la rappresentante dell’ILO. «Tutti in questo paese hanno sofferto».
Nei giorni che seguirono non riuscii a pensare ad altro. Passavo la maggior parte del mio tempo libero a raccogliere informazioni reperibili in rete e a perlustrare internet alla ricerca di qualcosa che potesse essermi sfuggito. Durante la ricerca mi resi conto per la prima volta di quanto poco era stato pubblicato. Non solo sul lavoro forzato: non c’era praticamente nessuna informazione sulle ferrovie.
La maggior parte delle informazioni che ero riuscita a trovare veniva da un archivio digitale dei quotidiani nazionali: articoli di propaganda sui generali che inauguravano nuove tratte o ponti facendo lunghi discorsi sconnessi sull’importanza dello sviluppo.
In pratica non c’era nessuna copertura indipendente, nessun blog e nemmeno sondaggi o rapporti tecnici. Per giorni passai al setaccio le librerie nei dintorni del mio appartamento, che vendevano di tutto – fotocopie rilegate di annuari della giunta, bilanci e storie militari scritte da generali in pensione – ma non trovai niente nemmeno lì. Dalle conversazioni con amici e colleghi capii che anche loro ne sapevano pochissimo. La maggior parte delle persone con cui parlai, compresi alcuni giornalisti locali, non sapeva niente delle ferrovie costruite dai militari e le nostre conversazioni, più che fornire risposte, sollevavano altri interrogativi.
Da giornalista, fu proprio la mancanza di informazioni a farmi appassionare all’argomento. Nel mondo in cui vivevo e che pensavo di conoscere, l’idea che si potessero costruire migliaia di chilometri di ferrovia senza un briciolo di attenzione o di scrutinio da parte dei cittadini era assurda. Fuori dal mio paese, e persino nel Myanmar in transizione, dei principali progetti pubblici si scriveva molto fin da prima che venissero realizzati e poi si discuteva, si analizzava e si documentava ogni fase della costruzione.
Ma il silenzio intorno alle ferrovie del Myanmar sollevava una questione ancora più importante: se i cittadini non sapeva nulla di una cosa rilevante come la rete ferroviaria nazionale, di quante altre cose erano all’oscuro?
Più pensavo alle ferrovie, più mi ossessionava l’idea di percorrerle. Immaginavo i binari come un filo narrativo che collegasse i vari aspetti di una storia che la giunta del Myanmar aveva fatto di tutto per nascondere. In un paese in cui le dicerie assumevano costantemente la dimensione di fatti, le ferrovie erano un raro documento storico che non poteva essere facilmente cancellato.
Seguendo fisicamente i binari costruiti dai militari avrei potuto tracciare l’espansione fisica del regime a partire dalle rivolte del 1988. Avrei appreso come la giunta aveva governato il paese durante i decenni che avevano preceduto la fase di transizione, illuminando, per estensione, le dinamiche politiche della fase più recente, in cui sembrava che i militari si stessero finalmente allontanando dal potere. In quel periodo in Myanmar si respirava un’atmosfera di progresso, si aveva la sensazione che i segreti a lungo taciuti avrebbero finito per essere rivelati e io pensavo al mio viaggio come a un modo per rivelare una piccola parte della verità.
Quando parlai ai miei colleghi del progetto di lasciare il giornale e seguire i binari in tutto il paese per scoprire perché erano stati costruiti, facendo un viaggio che secondo le mie previsioni doveva durare qualche mese, risero e mi dissero che ero pazza. Mi raccontarono storie inquietanti, di treni che saltavano in aria sulle mine e vecchi ponti che crollavano facendo precipitare le carrozze nei dirupi. Una di loro mi consigliò di portare con me dello spray al peperoncino, per sicurezza.
«Se qualcuno dovesse cercare di rubarti qualcosa, dovrai poterlo spaventare», mi disse. E aggiunse, sinistra: «Farai meglio a portare anche un coltello».
I colleghi mi consigliarono anche di vestirmi in modo tradizionale – con i sarong che qui chiamano htamein, che si indossano abbinati a bluse in tinta – per essere accolta meglio nei villaggi più remoti. Dato che quel tipo di abiti è confezionato su misura, mentre attendevo che un sarto finisse di preparare quelli che avevo ordinato, entrai in un vicino negozio di antiquariato. Conoscevo il proprietario, un ex geologo, e gli parlai del mio progetto di viaggiare per tutto il paese.
«Siediti, ti prego», mi disse mentre frugava nei cassetti della scrivania. Dopo un po’ ne estrasse una medaglietta d’ottone della dimensione di una grossa moneta che, attorno a una striscia di ceramica blu, portava inscritte, in birmano, le parole: «Cento anni di ferrovie del Myanmar». Era una medaglia commemorativa del 1977, celebrava il centenario dell’inaugurazione della prima linea. Insistette per regalarmelo.
Con la medaglietta riposta nello spallaccio dello zaino presi un aereo per Dawei, nell’estremo sud del Myanmar. Mi sembrava il punto di partenza più ovvio per il mio viaggio, perché la maggior parte delle informazioni che ero riuscita a trovare riguardava proprio la linea meridionale. La vicinanza della Thailandia aveva reso un po’ più facile, per le storie dei rifugiati, raggiungere il mondo esterno. A Dawei c’era anche una società civile molto vivace. Immaginavo che lì avrei incontrato attivisti, storici e scrittori che avevano documentato gli eventi degli anni Novanta e che sarebbero stati in grado di presentarmi ai loro omologhi in altre regioni più isolate. Da Dawei avrei preso un treno in direzione nord e poi avrei fatto il giro del paese in senso orario, attraversando prima Yangon e il delta, quindi la zona arida di Magway e gli stati etnici, per arrivare infine a Naypyidaw, la nuova capitale fatta costruire dalla giunta militare.
Traduzione di Alessandra Neve
Credits
Il testo, qui riportato in traduzione con il consenso di Clare Hammond, è un estratto del suo libro On the Shadow Tracks – A Journey Through Occupied Myanmar, pubblicato il 6 giugno 2024 da Allen Lane. L’immagine in alto, scattata dall’utente Wikimedia kallerna il 23 dicembre del 2019, ritrae un treno della linea Bagan-Mandalay in sosta nella stazione di Myngyan.

Clare Hammond, giornalista britannica, collabora con la Ong Global Witness per realizzare indagini su corruzione, conflitti e sfruttamento delle risorse naturali. Per Global Witness ha svolto indagini sul prelievo illegale di minerali rari e rubini in Myanmar che sono state riprese da molte testate, fra cui Associated Press, BBC, e Al Jazeera. Prima di trasferirsi a Yangon, dove ha vissuto dal 2014 al 2020, ha lavorato a Hong Kong come giornalista finanziaria, occupandosi di banche e mercati finanziari asiatici. A Yangon invece è diventata digital editor di Frontier, la principale testata investigativa del Myanmar. Vincitrice di una borsa della Google News Initiative Innovation Challenge, Hammond ha guidato la trasformazione digitale della newsroom di Frontier, ispirandosi al lavoro innovativo fatto da Maria Ressa con la testata filippina Rappler, e ha raccolto intorno a sé una squadra di reporter che si occupava di contrastare la disinformazione. Nello stesso periodo, grazie a una borsa del Pulitzer Center on Crisis Reporting, ha inviato reportage pluripremiati dal Myanmar e dal Bangladesh ad Al Jazeera, Bloomberg, The Guardian, NPR e The Economist.