
Sul Pacifico, verso l’Alaska
Da bordo del «Princesse Alice» lungo la costa della British Columbia [Luglio 1924]
| di Arnaldo Cipolla |
Mi sono imbarcato a Vancouver su di una nave che va in Alaska. Delle impressioni americane e canadesi, cioè dei territori attraversati per raggiungere il porto di Vancouver dove ho ripreso il mare, parlerò al ritorno. Per ora vi offro l’Alaska only, l’Alaska sola. Ce n’è abbastanza per discorrere lungamente.
Da noi quando si dice Alaska, si pensa ad un paese come la Lapponia, vale a dire ad una regione limitata. L’Alaska viceversa è quasi un altro continente, un’altra America. Il viaggiatore che, venendo da New York, arriva a San Francisco e si trova in faccia al Pacifico, non immagina che al Nord si protenda altrettanta terra eguale in lunghezza alla sterminata che ha percorso in treni a centoventi chilometri l’ora.
È soltanto da un anno che l’Alaska è entrata nel dominio del turismo americano, invadente e colossale come tutte le manifestazioni di questo paese meraviglioso.
E per cominciare dirò che è lontana. Andare dagli Stati Uniti oppure da Vancouver, che è canadese, all’Alaska è come recarsi dall’Egitto all’estremo Nord dell’Europa. Corrono più di mille miglia marine da Vancouver ai primi porti della costa meridionale dell’Alaska e comunicazioni mediocri. E poi vi è tutto il massiccio dell’Alaska, vasta come mezza Europa.
Un viaggio in Alaska, è sempre un pellegrinaggio nel paese della leggenda.
Non vi è luogo al mondo che, come l’Alaska, offra dei contrasti così estremi di esaltazione e di desolazione, nessuno che rinserri un’ambiguità più impressionante. Quel semicontinente, trent’anni fa, era un deserto. Divenne fulmineamente l’attrazione folgorante di tutta un’umanità che vi accorse abbagliata dalla scoperta dell’oro. Si diceva che la polvere d’oro ingiallisse, nel breve periodo del disgelo, la venatura delle sue sterminate correnti impetuose. La chimera fu creduta e l’Alaska, per qualche anno, fu il teatro di un’epica lotta, libera da ogni freno e da ogni legge, fra il parossismo degli uomini bianchi, gialli, negri, venuti da ogni punto d’America e d’Asia, decisi a strapparle il suo tesoro, e l’avversa natura che gelosamente lo difendeva.
Tutto era avverso alla bramosia d’oro degli uomini e delle donne (poiché numerose furono anche le donne fra i cercatori d’oro d’Alaska, nel periodo della gold fever, della febbre dell’oro): l’assenza di difese sociali nel territorio che gli Stati Uniti e il Canadà dominavano allora solo nominalmente, l’estrema esiguità dei nuclei indo-esquimesi sparsi nell’immenso Paese, le altissime barriere montane e gl’immani ghiacciai della costa del Pacifico, quasi insormontabili, il regime torrenziale dei fiumi che videro a migliaia le zattere dei pionieri, che nei fiumi si lanciarono per discenderli a forza di corrente e penetrar nell’interno, sfasciarsi contro le roccie o perire nei gorghi delle infinite rapide; e soprattutto il gelo, l’inverno dell’Alaska, che dura otto mesi, che impedisce ogni lavoro nella terra aurifera, che chiude ogni via di comunicazione, all’infuori dei tragici trails, dei sentieri invernali per slitte, nella tundra o nella foresta boreale, vie della morte per gelo, della rapina e dell’assassinio.
Le febbre dell’oro non durò che pochi anni, dopo di che l’Alaska ritornò di nuovo un deserto. Oggi l’Alaska conta appena 50 mila anime fra indo-esquimesi, meticci ed immigrati bianchi.
In altri paesi che ospitarono folte umanità e che oggi non sono più che terre morte, abitate da nomadi o disabitate affatto (talune vaste plaghe in Asia Minore, in Mesopotamia, in Mongolia) il dramma della scomparsa degli uomini è troppo lontano nel tempo perché possa effettivamente uscire dalla sua cornice storica e letteraria ed appassionarci.
Il dramma dell’Alaska invece è di ieri; le metropoli di case di legno sono ancora in piedi, il caldo sole delle giornate boreali estive, dalle venti ore di luce viva, non le ha ancora spaccate del tutto e i ghiacci invernali non cancellarono peranco la loro desolata topografia geometrica di dimore di fantasmi, attraverso le quali galoppano mandrie di libere alci, facendo risuonare con i loro zoccoli il tavolato che ricopre le strade.
L’Alaska, insomma, getta, starei per dire, coloro che si avvicinano dal mare ai ghiacciai della catena del S. Elia, fuori del pianeta. Sembra un Paese marziano come le regioni del centro africano coperte dalla foresta equatoriale. È una terra dove, al di là delle montagne costiere, per tutta la sterminata estensione del bacino dell’Yukkon, scavando per un metro si trova il ghiaccio eterno e la terra è quasi dovunque cosparsa di pagliuzze d’oro. È la regione americana maggiormente squassata dai terremoti e che contiene, nelle sue isole meridionali, i vulcani più poderosi del continente.
Sono in viaggio dunque. Partito da Vancouver ieri sera alle nove. Imbarcato su di una navicella che si dà delle arie da bastimento di lusso per trasportare i turisti americani a veder quello che i turisti europei vanno d’estate ad ammirare al Capo Nord: esquimesi, ghiacci, aurore boreali, sole a mezzanotte. Bastimento zeppo. Non vi sono che gli americani e i loro primi cugini, i canadesi dell’Ovest, capaci di sopportare una simile agglomerazione a bordo di una nave da diporto.
Gente di tutti gli Stati d’America. L’ho già detto, l’Alaska è di moda. L’ha resa tale il presidente Harding, morto appena tornato dall’Alaska per le fatiche subite visitandola. Chi crede alla iettatura può fare gli scongiuri del caso. Gli americani non ci credono, ma pel viaggio in Alaska si assicurano tutti. L’assicurazione la fa l’impiegato che a Vancouver vi dà il biglietto del viaggio in mare sino a Skagway o ad Anchorage, che sono i punti terminali della navigazione turistica.
Il viaggio da Vancouver a Skagway dura quasi una settimana, ma è una traversata marina veramente unica al mondo, poiché si scivola per tutto quel tempo fra i canali – veri fiordi longitudinali – formati dalle innumerevoli isole che di continuo accompagnano la costa della Columbia canadese prima e poi quella dell’Alaska. Coteste isole e la costa sono montuose e le catene di montagna hanno altezze superbe e si presentano coperte di nevi eterne e i fianchi densissimi di foreste di abeti. Mettete insieme il mare ridotto a stretto canale, a fiume vorticoso spesso, e le alte montagne nevose e i boschi sterminati e vedrete subito l’originalità del paesaggio. Originalità evidentemente è troppo poco. Ma economizziamo gli aggettivi per i giorni prossimi, quando navigheremo lungo i ghiacciai delle grandi montagne costiere dell’Alaska, che toccano i 7000 metri d’altezza.
La partenza da Vancouver non ha avuto niente di speciale. (Più avanti, descriverò anche Vancouver, la bella città dove arriva l’alito del Giappone e dove i giapponesi fanno finta di rappresentare la parte di plebe dedita ai lavori poco nobili, gli stessi del resto che disimpegnano numerosi connazionali nostri dell’Est).
Sono sinceramente stupito per il numero esorbitante di vecchie americane venute a bordo per andare a veder l’Alaska. Una particolarità notevole americana è proprio questa delle vecchie signore in viaggio e in perenne funzione di romper le tasche al prossimo. Da noi la donna che ha passato i 50 anni, sta generalmente ferma e vive con quella moderazione e con quello spirito incline alla rinuncia e alla tolleranza, che è frutto dell’età, dell’esperienza e della stanchezza della vita.
In America, invece, la vecchia signora è sempre in moto da un capo all’altro dell’Unione, in atteggiamento e funzione di controllare la vita materiale e morale dei centoventisette milioni d’esseri che formano le nazioni americana e canadese, modello in diciottesimo, quest’ultima, della prima.
Mi vado sinceramente convincendo che i tre quarti dei controsensi che l’America va architettando a stupefazione del mondo, di cui si dichiara senza modestia l’arbitra, sono dovuti alle vecchie signore che qui paiono galvanizzate da una vita violenta e talvolta selvaggia. (L’altro quarto, come si sa, delle assurdità di cui l’America s’adorna, deriva per metà dal clero anglicano, e per l’altra metà dall’intolleranza e dal fanatismo nazionalista).
Ma alla donna e soprattutto alla vecchia americana fondatrice degli ospedali per i cani ed altri animali meno fedeli, ispiratrice della «standardizzazione» del Continente e dea tutelare della colossale atmosfera di noia che lo avvolge dall’uno all’altro oceano, spetta il dominio incontrastato delle sue idee, dei suoi gusti e delle sue tendenze.
Appena distaccatici dal molo, uno steward del piroscafo, munito di tromba, è salito sul ponte superiore ed ha iniziato sulla gran calma del canale un interminabile «a solo» con quello strumento. Sulle prime credevo si trattasse di un segnale per il pranzo, poi ho capito che era l’addio alla terra comune, senza possibilità di avventure, che la tromba esprimeva. Si va verso un mondo di leggenda e di incredulità. L’anima americana domanda un’espressione artistica dello speciale stato spirituale formato dal trapasso dall’assoluta e metodica uniformità della sua vita, a quella di un paese d’avventura. E il cameriere-trombettiere, suona e continua a suonare una specie di segnale del silenzio che se la durasse così su di una nave italiana i passeggieri l’avrebbero fatto smettere d’urgenza e se si fosse ostinato a continuare, lo strumento (tromba sfiatata solitaria) sarebbe finito di certo in mare. Invece qui tutti lo ascoltano come se si trattasse di Paganini.
Il ponte è pieno di ombre. Gruppi di figure piuttosto tozze, sembrano assorte nella contemplazione delle luci di Vancouver che punteggiano l’aria lattiginosa. Sono degli uomini, certamente. No, sono donne, le vecchie e per lo meno le ultra mature signore di cui vi parlavo, vestite tutte da turisti di genere maschile. In Alaska le donne ci vanno vestite da uomo. È stabilito così. Da che Servais, il poeta americano dell’Alaska, ha vestito le sue eroine, compagne dei cercatori d’oro, con i calzoni e gli stivaloni, le donne non possono decentemente sbarcare in Alaska che in cotesta guisa.
È vero che la stragrande maggioranza delle turiste americane in questa stagione nella quale l’America sembra agitata da una vera frenesia di vita au grand air (Montagne Rocciose, strade di California, i cento National Parks, i laghi, i luoghi tutti esaltati da una réclame irresistibile, imperiosa, magnificante bellezze che il più delle volte sono per noi europei una delusione, nereggiano di milioni di automobili) porta l’abito maschile.
Tuttavia un milionario di San Francisco che ha fatto i denari a furia di spedir treni espressi di cocomeri e di pesche dall’Ovest all’Est – lo dice lui dopo cinque minuti di conversazione e dice pure che va in Alaska attratto più che dal piacere del viaggio, dall’idea di stabilire una cannerie a Juneau – mi confessa che sua figlia che viaggia con lui, non porterà mai i calzoni. Come tipo di padre americano, deciso a far rispettare la sua volontà dalla figliuola, nel Paese dove l’autorità dei genitori è sconosciuta, mi pare degno di nota. Sopravviene la figlia. È una bella ragazza che, a parte i capelli rasati sotto la nuca, vestita, come appare con gusto, sarebbe deliziosa in qualunque parte del mondo.
Tanto per dirle qualcosa le suggerisco che sembra una parigina. Non l’avessi mai detto! Due ore dopo, quella perla di padre autoritario, girava con faccia rassegnata per il piroscafo, con un certo numero di radiotelegrammi vergati dalla figlia che ordinavano ad un grande atelier della Market Street di San Francisco, nuove toilettes estive da spedirsi subito a Seattle.
«Mia figlia non ha torto – conchiude il padre dopo aver spedito i radio – dal momento che anche voi avete giudicato che essa veste come una parigina. A me basta che non porti i calzoni».
America! Inverosimile paese dove la gente crede a tutto quello che stampano i giornali, dove, con una parola buttata a caso, si può determinare un uomo e peggio ancora una donna, a cangiare di punto in bianco il proprio destino! Terra di candore e d’ingenuità (non voglio dire d’ipocrisia), che crede di aver raggiunto la perfezione sociale, solo perché il Presidente è costretto a ricevere chiunque e i treni hanno democraticamente una classe unica!
A proposito d’ingenuità e d’ipocrisia: Siamo entrati nel Canale di Georgia, fra la grande isola di Vancouver e la costa, sotto i dardi luminosi di molteplici proiettori. Sono collocati in alto, al limite della stupenda foresta di Stanley, il parco della città marittima canadese del Pacifico, che contiene alberi così colossali e vetusti che figurano fra gli esseri più antichi della terra. Alcuni sorpassano infatti i 5000 anni di vita! La luce illumina noi ed illumina pure certe sterminate zattere fatte di innumerevoli tronchi provenienti dai boschi delle rive del Fraser, il fiume che sbocca nella baia chiusa, dove sorgono Vancouver canadese, Seattle e Tacoma americane. Le zattere, che sono lunghe sino a duecento metri e larghe cinquanta, vanno, rimorchiate da vaporetti, alle segherie elettriche mosse da cascate, disseminate in ogni punto della baia. Il navigare di coteste zattere è permesso soltanto durante la notte, con l’alta marea, che qui, lungo il Pacifico, ha sei metri di differenza di livello sulla bassa marea.
Credevo che i proiettori illuminassero la strada alle zattere o fossero lì per qualche ragione militare o di navigazione. Neppur per sogno! Sono uno degli elementi di quell’enorme macchina poliziesco-burocratico-finanziaria che è il Proibizionismo. Il Canadà, che scimmiotta in tutto l’America, è proibizionista a metà. È lo Stato che fa il vinaio e il liquorista. Qui sorveglia che la baia scoperta da Juan de Fuca non sia violata dai contrabbandieri messicani. Vi sono pure torpediniere, mas e aeroplani che fan la guardia e tiran cannonate alle navi sospette. Un’organizzazione bellico-proibizionista insomma, che non ha nulla da invidiare a quella degli Stati Uniti sulle rive dell’Atlantico. La guerra del vino passerà probabilmente alla storia come la più lunga guerra dell’universo perché tutti: contrabbandieri, rivenditori, polizia e clero presbiteriano protestante, sono interessati a che essa non abbia mai fine, perché tutti vi guadagnano sopra in modo fantastico.
Si dice quest’oggi in America che la professione del poliziotto municipale, statale e federale sia diventata fra le più ambite, soprattutto perché i poliziotti stanno facendosi milionari per i lauti guadagni accumulati concedendo la loro protezione all’infinita schiera di «bootleggers», cioè di fabbricatori e di spacciatori di bevande alcoliche. E il più grazioso è stato il risultato ottenuto dall’aumento degli agenti doganali sulla frontiera fra gli Stati Uniti e Canadà dalla parte americana fra le provincie di Quebec e lo Stato di Vermont. In ragione della misura, il whisky sul mercato di New York, avrebbe dovuto aumentar di prezzo, essendosi apparentemente reso più difficile il contrabbando dal Canadà agli Stati dell’Unione. Invece ebbe un drop, un’abbassamento, impressionante, particolare che sta a provare che gli agenti, aumentando, siano diventati meno esigenti, cioè che il whisky passa il confine più facilmente. […]
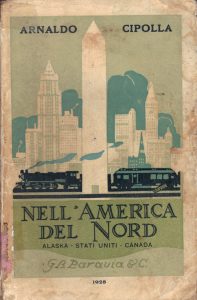 (Il brano proposto è l’inizio del libro di Arnaldo Cipolla Nell’America del Nord. Impressioni di un viaggio in Alaska, Stati Uniti e Canada, Paravia, Torino 1928, pp. 1-9. L’immagine in alto è una riproduzione della cartina geografica allegata al libro stesso.)
(Il brano proposto è l’inizio del libro di Arnaldo Cipolla Nell’America del Nord. Impressioni di un viaggio in Alaska, Stati Uniti e Canada, Paravia, Torino 1928, pp. 1-9. L’immagine in alto è una riproduzione della cartina geografica allegata al libro stesso.)




